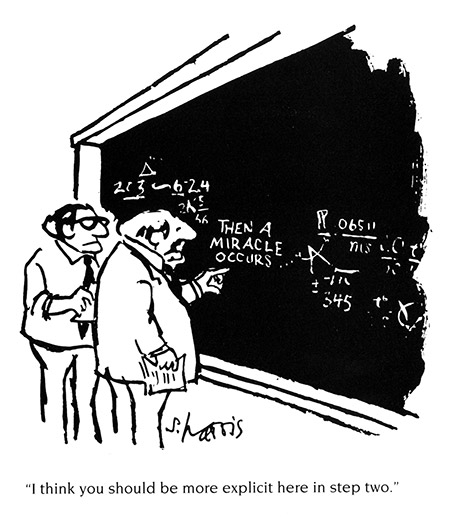Con ieri ho portato a casa un'altra casella del libretto, sulla strada ancora tutta in salita per diventare Dottore Magistrale (ma in latino suona meglio, sarò "Maestro").
Si tratta dell'esame di Applicazioni Fisiche della Teoria dei Gruppi, che al di là dello spreco di maiuscole significa algebre di Lie, con particolare riferimento all'algebra del gruppo di Poincaré e ad SU(3) dell'interazione forte; esame che avevo messo in conto di fare per la prima-seconda settimana di novembre ma che è lentamente scivolato fino a ieri, complice anche la continua procrastinazione (dieci giorni, di giorno in giorno) del docente, preso dal dover far "supplenza" ad un collega assente.
Esame oggettivamente non difficile, che in sede di prova scritta (come al solito, è tipico degli esami con Girardello) ha avuto come principale difficoltà capire cosa lui volesse - né è facile all'orale, ma almeno lì continua a correggerti finché imbocchi la strada giusta; difficile capire cosa lui volesse, e tra l'altro il professore giustamente si lamenta, perché basta andare a chiedergli e ti spiega. Solo che, mentre fai l'esame, difficilmente ti passa per la testa che la risposta che tu daresti alla domanda non sia quella che vuole lui...
Pagando questo scotto, alla fine è andata bene e sono riuscito a portare a casa un 28, che credevo di aver buttato alle ortiche impelagandomi in tableaux di Young che quasi non sarei nemmeno tenuto a sapere, avendo evitato l'esame di Metodi Matematici avendone affrontato due terzi degli argomenti a Fisica Matematica il terzo anno.
Anche se per indole sarei portato a mettermi sugli allori una settimana, non c'è tempo. Anche perché tra un esame e l'altro sarebbe anche il caso di fare un po' di ricerca, e quindi devo mettermi a ripassare i miei cari vecchi bialgebroidi.